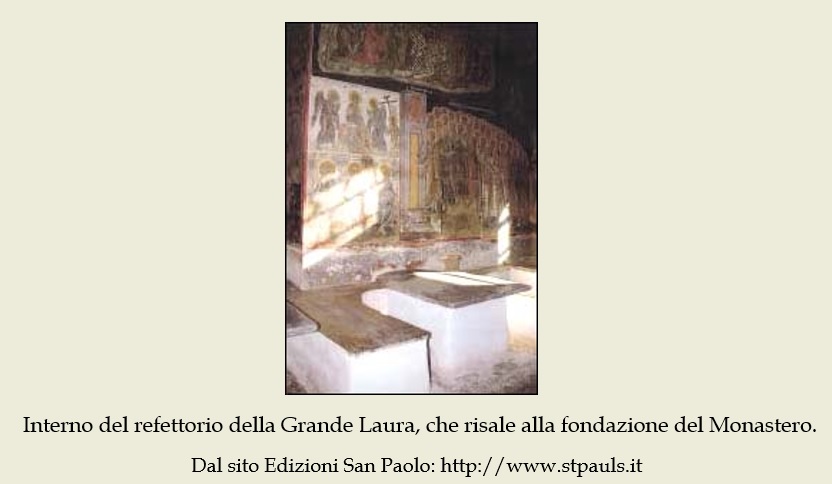
LA CONVERSIONE DI SANT'ATANASIO ATONITA
ALL’IDEALE CENOBITICO E L'INFLUENZA STUDITA
di Julien Leroy, O.S.B. - En-Calcat
Estratto e tradotto da: “Le Millénaire du
Mont Athos 963-1963”, Éditions de Chevetogne
La fondazione del Monastero della Grande Lavra deve essere considerato un evento
epocale nella storia del monachesimo orientale. Non solo perché la Lavra era, ed
è tuttora, il monastero più importante della Santa Montagna, non solo perché
questa fondazione ha preparato quella di altri due monasteri atoniti tra i più
illustri del mondo bizantino, Vatopédi e Iviron, ma perché segna un punto di
svolta che sarà a lungo decisivo nella spiritualità monastica dell'Athos.
Sant'Atanasio, il fondatore della Lavra, introdusse, non senza difficoltà, la
vita cenobitica su una terra che era la roccaforte della vita eremitica e
dell'esicasmo
[1]. Egli ha provocato una specie di
conversione collettiva dalla spiritualità atonita all'ideale cenobitico. Questa
conversione, è vero, non fu totale; eremitismo e tendenze esicaste sono sempre
state abbondantemente rappresentate sulla Santa Montagna, ma l'influenza del
cenobitismo fu così importante da modificare profondamente l'aspetto della
penisola, a partire dal suo aspetto più materiale, quello che attira ogni anno
tanti turisti. I venti monasteri sovrani, anche se attualmente non sono più
cenobitici, sono tutti originariamente dei
coenobia. Le skiti
[2], siano esse skiti idiorritmiche
[3] come Nea Skiti, Sant’Anna o Kavsokalyvia,
o skiti cenobitiche come il Serail o la skiti rumena del Prodromo, hanno, in
ultima analisi, un'origine cenobitica. Cosa sarebbe il Monte Athos senza questi
grandi monasteri che lo rendono così splendido? Ed il numero dei monaci che vi
abitano è maggiore, e di molto, di quello dei calogeri
[4] che, a diversi titoli, conducono la vita
esicasta nelle “kellia”
[5] e negli eremi
[6].
Ma la bellezza dei monumenti, la natura pittoresca del loro sito, la ricchezza
dei loro tesori non sono nulla in confronto alla ricchezza spirituale. Tuttavia,
sull’Athos, questa ricchezza deriva soprattutto dalla diversità delle
spiritualità che coesistono ed a volte si scontrano. Sotto l'uniformità
dell'abito si nascondono stili di vita molto diversi, quindi spiritualità
diverse e talvolta complesse
[7].
Tutto questo lo dobbiamo alla fondazione della Lavra. Anche se, prima
dell'arrivo di Atanasio, i monaci vivevano fianco a fianco e formavano dei "monai"
(dal greco: dimore), non si poteva ancora parlare di colonie di cenobiti. “Per
difendersi dagli animali selvatici e per aiutarsi a vicenda, molti eremiti
costruiscono le loro capanne, più o meno vicini tra di loro. Stimolati
dall'istinto sociale, si raggruppano, formando così una sorta di villaggio
semi-eremitico molto sparso, dove regna una disciplina embrionale e dove prende
forma un'organizzazione collettiva. Si riuniscono in determinati periodi e, la
domenica e nei giorni festivi, si recano tutti in una cappella comune per
assistere alle funzioni"
[8].
Se il monastero fondato tra l'869 e l'873 vicino a Hiérissos da Giovanni
Kolovos è un cenobio e se la sua giurisdizione si è estesa per qualche tempo sui
territori dell’Athos, sembra che i monaci atoniti abbiano cercato, riuscendovi,
di sfuggire a questa giurisdizione incompatibile con il loro ideale eremitico
[9]. Nessuna traccia, in questa prima fase
della storia atonita, di una qualunque influenza della vita cenobitica. Anche
Sant'Eutimio il Giovane, che per diciassette anni visse una vita autentica da
cenobita presso il monastero "tôn
Pissadinôn" nell'Olimpo della Bitinia
[10], non cerca di vivere durante il suo
soggiorno ad Athos, alla fine del secolo IX, il suo ideale primitivo e, quando
fonda un cenobio, lo fa fuori dalla Santa Montagna vicino a Salonicco
Questa conversione della spiritualità atonita all'ideale cenobitico è la
conseguenza di un'altra conversione: quella dello stesso Atanasio. Niente,
infatti, lo aveva preparato a diventare il paladino del cenobitismo, né le sue
prime aspirazioni di vita monastica, né la formazione ricevuta sul Monte Kymina,
né il clima spirituale che trovò sulla Santa Montagna.
La vocazione monastica del piccolo Avraamios (Abramo) di Trebisonda si è
manifestata molto presto. Il suo biografo
[11] racconta con ammirazione come gioca a
fare il monaco con i suoi compagni. Nei loro giochi devoti lo considerano
persino il loro legislatore, ma già si tratta di "vita solitaria" e nessuna vita
comune. Più tardi questa vocazione si affermerà e si manifesterà in modo meno
infantile. Da studente, Avraamios vive come un monaco, ma un monaco di tipo
consolidato: gli piacciono solo la solitudine ed il silenzio, al punto che non
accetta di condividere i pasti con la sua famiglia adottiva, e conduce una vita
molto austera, mangiando pane e dormendo su di una sedia!
[12] A Costantinopoli, tuttavia, non può
ignorare l'esistenza dei moltissimi monasteri cenobitici che si trovano nella
città
[13] e dall'altra parte del Bosforo vede la
montagna, anch'essa santa, dell'Olimpo i cui
coenobia sono famosi nella città
imperiale
[14]. Ma è durante un viaggio ad Abido
[15] che scopre la bianca vetta dell'Athos ed
ecco che è assolutamente affascinato da questa terra che per lui è eminentemente
santa perché è la patria dei kellioti (dimoranti nelle
kellia) e degli eremiti
[16]. Nessuno dei grandi egumeni bizantini
riceve le sue confidenze; l'unica personalità che lo conquisterà sarà san
Michele Maleinos
[17], giunto a Costantinopoli per affari.
Avraamios diventa suo discepolo; va con lui al monastero di Monte-Kyminas
(fondato da Michele), e riceve l'abito dalle sue mani. È stato scritto più volte
che fu nel monastero di Michele Maleinos che Avraamios, diventato fratello
Atanasio, fu iniziato al cenobitismo e più in particolare alla concezione
studita della vita cenobitica
[18]. Niente è meno esatto. Conosciamo molto
bene l'ideale monastico di san Michele Maleinos. Il suo discepolo Teofane, che
visse al suo fianco per quarant'anni, dal 921 al 961
[19], e quindi all'epoca in cui anche
Atanasio era discepolo di Michele, ci ha lasciato una biografia del santo che
pullula di dettagli concreti e di preziose annotazioni. Il monastero in cui
Maleinos iniziò la sua carriera monastica non sembra essere stato un
coenobium
[20], ma una comunità che prepara all’hésychia,
nella migliore tradizione del monachesimo del Monte Olimpo
[21]. Sono rivelatori dei dettagli molto
piccoli: così Michele indossa solo una tunica come vestiario e cammina scalzo.
Ad ogni modo dopo tre anni, "la sua anima brucia del fuoco dell’anacoresi”. Si
ritira su di una roccia dove conduce una vita solitaria ed il suo ascetismo;
prende, ad esempio, un solo pasto tra lunedì e sabato. Certo, il suo biografo,
da perfetto discepolo, condivide la concezione del suo maestro e non nasconde la
sua ammirazione per la vita di solitudine. Sempre più spinto dal desiderio dell’hesychia,
Michele sprofonda in una solitudine più profonda. La dieta diventa ancora più
austera
[22]. Michele finisce anche per abbandonare
l'unico compagno della sua solitudine, per essere veramente e totalmente solo
nella capanna che si è costruito. Quando i discepoli arrivarono, attratti dalla
sua fama di santità, costruì un monastero e scrisse per loro un
typicon che non abbiamo più; è chiaro
che questo monastero non è un cenobio; il nome di laura
[23] chiarisce abbastanza il fatto che, se si
conduce una certa vita insieme, è solo in modo transitorio e per prepararsi alla
vita solitaria.
Del resto, quando il biografo di Michele vorrà confrontarlo con i suoi
predecessori, lo metterà in parallelo con i santi Eutimio e Saba, i fondatori
delle laure palestinesi. Paragone tanto più eclatante in quanto sembra
riecheggiare il giudizio unanime dei cristiani di Costantinopoli. Se i Bizantini
non pensano assolutamente a paragonare Michele con Teodoro Studita - la cui
opera monastica aveva avuto un considerevole irraggiamento, che era morto solo
un secolo prima e che era uno dei loro illustri compatrioti - ma ai due santi
palestinesi - morti circa quattrocento anni prima e che avevano vissuto in una
terra lontana - è la migliore prova che tra l'ideale cenobitico dello Studita e
la concezione monastica di Michele Maleinos, non c'era nulla in comune.
È in questa laura del Monte Kyminas che il giovane Atanasio riceverà la sua
formazione monastica. Possiamo vederne l'orientamento. Per quattro anni rimase
alla laura per prepararsi attraverso una certa vita comune alla desiderata
solitudine; durante questo necessario tirocinio fa le concessioni imposte
dall'obbedienza e rinuncia temporaneamente alle sue austerità, ma non appena è
autorizzato dal suo padre spirituale ad andare in cerca dell’hesychia,
riprenderà le sue austerità originali. È ovvio che Atanasio si trova
perfettamente a suo agio in questa vita ed in questa spiritualità. Non troviamo
la minima traccia di alcun conflitto interno nel racconto della sua permanenza
con Michele Maleinos. La prima prova che si presenterà sarà per lui un segnale.
Piuttosto che accettare, con l'incarico di superiore della laura, un genere di
vita che giudica incompatibile con la sua vocazione, preferisce partire per il
meraviglioso paese che aveva intravisto al largo di Abido, per vivere lì
pienamente il suo ideale.
Il suo biografo ce lo descrive entusiasta di ciò che trova sulla Santa Montagna:
"ammirava la vita eremita" che vi si conduceva… I monaci atoniti non erano dei
veri monaci? Non lavoravano la terra, non avevano muli o asini; si muovevano a
piedi, portando sulle spalle il loro unico mobilio: la stuoia su cui, giunta la
sera, si riposavano qualche breve ora
[24]; mangiavano solo i frutti che la
Provvidenza offriva loro od il poco pane e le verdure che portavano loro i
pellegrini. Atanasio è un uomo felice, che ha trovato l'ambiente ideale in cui
fiorirà la sua vocazione.
Cercherà costantemente questa felicità nella fedeltà al suo ideale primitivo, sia vicino all'eremo dello Zygos, sia vicino a Karyès [25]. "Egli conversa continuamente con Dio", ci dice il suo biografo. È vero che lavora un po', il che è scusato, "perché era un uomo" [26]. Dopo la visita alla Santa Montagna del Maestro Leone, Atanasio, sempre spinto dal suo ardentissimo amore per la solitudine, fugge sulla punta estrema dell'Athos, in un luogo chiamato Melana [27]. Non era solo la distanza che nella sua nuova capanna gli assicurava solitudine e silenzio, ma anche l'ambientazione desertica di questa straordinaria regione. Egli affronta eroicamente i demoni dell’accidia. Quest'anno di lotta ha sicuramente lasciato un segno profondo in lui; ha capito quali possono essere i pericoli della solitudine [28], ma dopo aver vinto queste dure tentazioni con la sua pazienza, è più che mai attaccato a questo ideale contemplativo; questo luogo gli diventerà più caro di ogni altra cosa. Quando Niceforo Foca [29] gli chiede le sue preghiere per la conquista di Creta e lo prega di venire ed unirsi a lui sul luogo delle sue battaglie, Atanasio esita così tanto a lasciare la sua solitudine, che ha bisogno della minaccia di formidabili sanzioni da parte dell'Epistasia [30] atonita per acconsentire. È allora che l'ideale monastico di Atanasio inizierà a piegarsi. Niceforo Foca dice che è pronto a lasciare il mondo per vivere con il suo padre spirituale Atanasio; c'è solo un ostacolo, non hanno un monastero. Niceforo si incarica del finanziamento di questa fondazione. Ma, attenzione a non prendere un abbaglio, la fondazione che progetta non è un cenobio; vuole che si costruiscano "celle di esicasti", cinque in tutto, certamente abbastanza lontane tra di loro, una chiesa dove, la domenica, gli eremiti possano incontrarsi per la liturgia, ed un refettorio per consumare i pasti insieme, quel giorno, prima di tornare alle loro celle solitarie È proprio una fondazione nel tipo del monastero di Michele Maléinos, tanto che Niceforo la chiama una "laura". Il nome le rimarrà. Forse questa non era una novità sulla Santa Montagna [31]. È proprio attraverso il nuovo egumeno della laura di Maléinos che Niceforo Foca trasmette i fondi destinati alla costruzione [32]. I primi lavori iniziano subito dopo, cioè alla fine del 961. Atanasio li conduce nello spirito che è sempre stato il suo: costruisce il kathisma (semplice dimora per un monaco solitario) che destina a Niceforo, sul fianco della montagna, a pochi minuti dall’attuale monastero di Lavra [33], e quindi organizza il suo eremo di Mélana. In quest’epoca la dieta è molto austera e conforme alla tradizione eremitica: pane, frutta ed acqua. Ma improvvisamente Atanasio sembra cambiare orientamento. Al katholikon (la chiesa principale) - quella che ancora esiste - aggiunge due cappelle; costruisce nuove celle, ma che non sono più "celle di esicasti"; le dispone in un rettangolo attorno al katholikon [34]. Di fronte alla chiesa costruisce il mirabile refettorio che ancora si vede, con le sue venti tavole di marmo, dove possono sedere duecentoquaranta “calogeri” (monaci di rito bizantino).
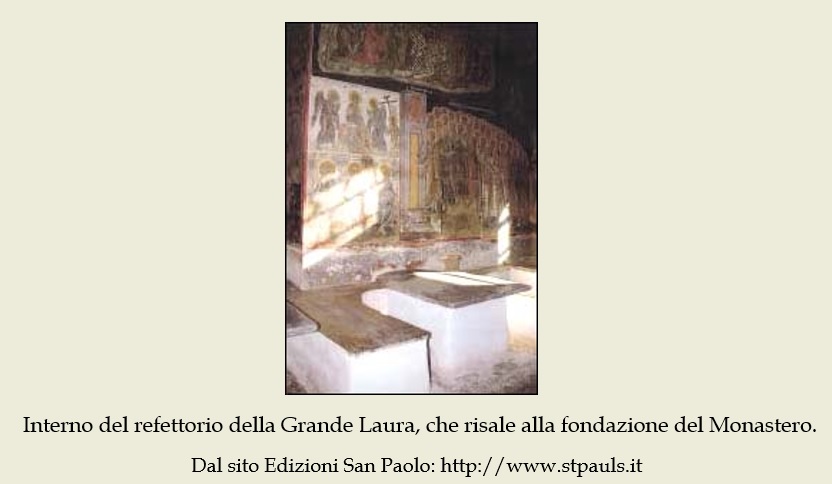
Atanasio pensa in grande! Questo insieme che ha appena realizzato e
che è stato tramandato quasi immutato fino ad oggi
[35], diventerà il prototipo di tutti i
monasteri atoniti. È probabile che la pianta di un
coenobium non differisse dalla pianta
del nucleo centrale delle laure
[36], ma gli edifici cenobitici sono molto
più grandi, perché le celle completano l’insieme abituale delle laure
[37]. Anche se nessun testo ci assicura che
Atanasio, a partire da un periodo successivo al 963, orientò decisamente la sua
spiritualità personale e la sua concezione di vita monastica verso il
cenobitismo, lo stupefacente complesso del monastero attesta, soprattutto quando
lo scopriamo arrivando dalla skiti
del Prodromo, che, costruendo la Lavra, Atanasio voleva farne un cenobio, ed un
grande cenobio.
Ma il fondatore non si accontenta di costruire; egli legifera; non è senza
ragione che il suo biografo pone subito dopo l'enumerazione delle costruzioni
intraprese in quell’epoca, diversi paragrafi in cui vengono studiati i vari
regolamenti che il santo stabilì per i suoi monaci.
Si capisce la violenta reazione degli antichi monaci di Athos che lo accusano di
aver distrutto le vecchie regole e lo affliggono per tutte queste costruzioni,
per la coltivazione della terra, per le piantagioni di viti e frutteti. In una
regione monastica fino ad allora gelosamente riservata all'esicasmo, o per lo
meno a delle forme di vita derivate dalla spiritualità contemplativa, Atanasio
introduce la vita cenobitica. Se c'è una certa somiglianza tra una laura ed un
cenobio, perché vi si vive una vita comune, la differenza tra i due stili di
vita è assolutamente radicale: la laura è solo un cenobio transitorio dove i
monaci si preparano ai combattimenti della solitudine
[38]. In altre parole, è un cenobio ordinato
alla contemplazione
[39]. Accanto al nucleo centrale sorgono le
molte celle degli esicasti che, dopo aver completato la loro formazione
spirituale, conducono la vita contemplativa. Il sistema delle laure, poiché è
solo un perfezionamento della vita eremita, poteva essere accolto senza
difficoltà dai monaci atoniti; la vita cenobitica era incompatibile con
l'esicasmo atonita. I monaci del Monte Athos, ed in particolare Paolo (del
monastero) di Xéropotamou, lo capirono bene; anche se in realtà le loro critiche
riguardavano solo l'aspetto più materiale del nuovo stile di vita monastica
introdotto da Atanasio, è contro la spiritualità cenobitica che insorsero.
L'imperatore bizantino Giovanni I Zimisce lo capì bene come loro, poiché scelse
come arbitro di questo conflitto l'egumeno del monastero di Stoudios
[40].
L'ideale cenobitico, infatti, dalla fine del VII secolo a Bisanzio porta il nome del monastero dove Teodoro fece rivivere la vita cenobitica di cui i Bizantini avevano perso la tradizione. Il monastero di Studios diventerà, e per molto tempo, il prototipo dei monasteri cenobitici [41]. Poiché a Lavra Atanasio aveva scoperto il valore del cenobitismo, non poteva che diventare il discepolo di san Teodoro Studita. Anche nei pochi testi che ci rimangono del fondatore della Lavra si trovano continuamente tracce dell'influenza studita. Nel suo Typicon, composto nel 970-971, dopo il suo viaggio a Costantinopoli, Atanasio introdusse una parte importante del Testamento di San Teodoro Studita, quello che raggruppa i precetti indirizzati al successore. Dei ventiquattro articoli inclusi in questo testo, Atanasio ne ha trattenuti quattordici. La maggior parte delle volte ha copiato fedelmente il suo modello, integrando, se necessario, tale o tal altra prescrizione. L'omissione degli articoli che non sono stati trattenuti da Atanasio, è facilmente spiegabile in generale: così i tre paragrafi 9, 15 e 16, relativi ai rapporti con le donne, senza dubbio non avevano motivo di esistere sulla Santa Montagna, dove la regola di avaton [42] era senza dubbio già in vigore. Il divieto fatto dalla Studita di distinguere tra il grande e piccolo abito non poteva essere incorporato nel Typicon, poiché a quel tempo era una consuetudine recepita [43]. Quanto all'obbligo imposto da Teodoro all'egumeno di spostarsi a piedi, od in caso di necessità su di un asino, doveva inevitabilmente scomparire da un regolamento redatto per un monastero stabilito in una regione solitaria e montuosa, dove il mulo era, ed è tuttora, l'unico mezzo di trasporto conveniente nella maggior parte dei casi.
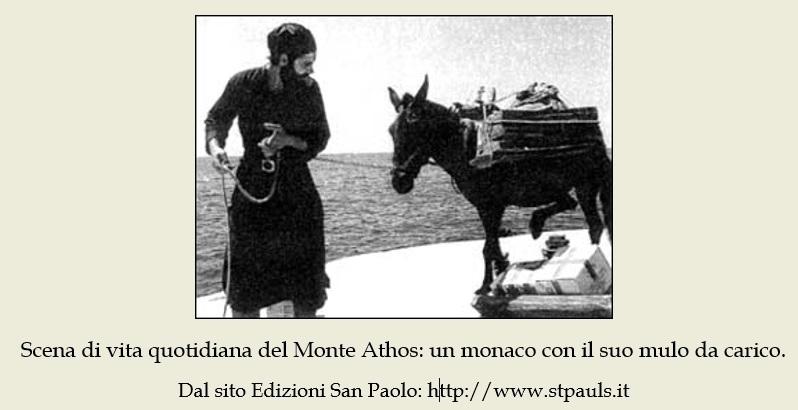
Ci spieghiamo meno,
invece, la sparizione della prescrizione concernente le catechesi
[44]. Comunque sia, prendendo a prestito dal
Testamento del grande riformatore del cenobitismo bizantino la maggior parte
delle istruzioni che intende dare al suo successore, sant'Atanasio si pone
deliberatamente sulla scia del monachesimo studita.
Ancora più straordinario è il prestito da un altro testo studita. L'ipotiposi
(che significa circa: gli abbozzi di
istruzioni. Ndt.) di Lavra, scritta da sant'Atanasio poco dopo la
trasformazione della laura in cenobio, si distingue molto visibilmente dall'ipotiposi
studita; egli vi ha apportato alcune modifiche importanti; ne ha tolto le usanze
proprie degli studiti, come il saluto fatto con le mani; ma ne conserva
l'essenziale, ne segue il piano generale e ne riproduce anche i lemmi
[45].
Così la dieta è, più o meno, la stessa che ci è specificata nell'ipotiposi
studita. Il lavoro, che occupava un posto considerevole nella vita quotidiana
degli studiti e nella loro spiritualità
[46],
ha negli scritti di Atanasio una durata approssimativamente uguale
[47].
La vita di Atanasio conferma questi dettagli. Possiamo intuire che le "diaconie"
hanno avuto un posto importante a Lavra come nel monastero di Studios, o più
esattamente come nei monasteri studiti dell'Olimpo
[48].
Troviamo in Atanasio,
come per Teodoro, la preoccupazione di alleggerire e facilitare il lavoro,
affinché non diventi opprimente
[49]. Insomma, suddivisa tra ufficio, lettura
e lavoro manuale, la giornata del lauriota somiglia a quella di tutti i cenobiti
che, dalla Bitinia all'Italia meridionale, erano gli eredi spirituali di Teodoro
Studita.
Sembra persino che Atanasio abbia voluto completare il lavoro legislativo di
Teodoro. L'egumeno del monastero di Studios aveva regolamentato la vita dei suoi
monaci
[50]. Lo aveva fatto con flessibilità,
lasciando alla libertà di ciascuno la cura di ravvivare questo regolamento
comune con i suoi contributi personali. Così Teodoro non ha stabilito regole per
il silenzio. Non ha per niente previsto dei momenti dedicati allo svago, non
imponendo in cambio uno stretto obbligo del silenzio. Lo studita pratica il
silenzio con una libertà che può degenerare, ma che nessuna regolamentazione
vincola. Inoltre, di tanto in tanto, Teodoro è obbligato ad alzare il tono per
frenare le chiacchiere, o anche per porre fine al vero frastuono, ad esempio
all’uscita dai servizi o dai pasti. Atanasio non intende modificare la
concezione del silenzio, ma istituisce dei supervisori che reprimono gli abusi.
Gli epistemonarchi (Ndt. Coloro a cui in un monastero è affidata la disciplina e
l'osservanza delle regole), che nel monastero di Studios erano responsabili solo
di ricevere accuse spontanee dai fratelli, ricevono a Lavra la missione di
vigilare sulla buona condotta dei fratelli; essi stimolano i ritardatari e
chiedono spiegazioni a coloro che vogliono lasciare la chiesa prima della fine
dei servizi; un portinaio è appositamente istituito all'ingresso della chiesa
per dare una mano agli epistemonarchi. Nel monastero, ed in particolare nel
refettorio, due epitereti (vigilanti) sono incaricati della sorveglianza dei
monaci. Troviamo presso Atanasio una preoccupazione per l'ordine e la regolarità
esteriore che non troviamo nella stessa misura nel monastero di Studios.
Queste
innovazioni sono in linea con le tendenze del cenobitismo. San Basilio non ha
mai pensato di dare ai suoi discepoli leggi diverse dalla Scrittura, né di fare
di loro qualcosa di diverso dai cristiani. Teodoro, che nondimeno voleva fare
della sua opera di riforma un ritorno a questo spirito evangelico di Basilio, fu
obbligato a stabilire alcune norme che specificassero le forme concrete della
fedeltà alla Scrittura; ma egli cercò di farlo con discrezione, poiché la sua
concezione del monastero-corpo-mistico
[51] implica la
diversità dei membri nell'unità della carità. Il fondatore di Lavra, aggiungendo
nuove prescrizioni a quelle di Teodoro, racchiude l'ideale studita in una
cornice più ristretta; di tempo in tempo la lettera assumerà sempre più
importanza, spesso a scapito dello spirito; i
typica diventeranno sempre più
lunghi, sempre più precisi e meticolosi
[52]. Il Vangelo
correrà il rischio di non trarne più vantaggio; si finirà per perdere di vista
l'ideale cenobitico primitivo che altro non era che l'ideale evangelico. Si
cercherà quindi di dare di nuovo vita all'istituzione cenobitica infondendole
un'altra spiritualità. L'esicasmo troverà lì la sua rivincita
[53].
Già in sant'Atanasio la concezione del cenobitismo non è così integrale da non
poter dare uno spazio, certamente molto limitato, alla ricerca di Dio attraverso
la contemplazione. Il fondatore di Lavra prevede che cinque dei suoi monaci
potranno vivere come esicasti. Teodoro Studita non ha mai ammesso questa
possibilità
[54].
Questo significa che Atanasio pensava che l'ideale esicasta fosse superiore
all'ideale cenobitico? Sarebbe un errore pensarlo. Egli si è spiegato molto
chiaramente: "A tutti voi affermo, davanti a Dio ed agli angeli, che coloro che
perseverano nell'autentica sottomissione, rimanendo nell'amore di Dio e nella
devozione per gli altri, non saranno inferiori a coloro che lottano all’estremo
nell’esichia; al contrario, riconosceremo che sono superiori a loro e
meriteranno di ricevere le corone eterne dal buono ed integerrimo giudice»
(Meyer, op. cit., 118, pp.18-23).
Vuole così lasciare una possibilità eccezionale, a coloro che non trovano nella
vita cenobitica la propria spirituale fioritura, di trovare il loro vero posto.
Perché per Atanasio, come per lo Studita, la vita cenobitica è pienamente
definita dall'hypotegé, la
“sottomissione” (ad un padre spirituale): "Quanto a coloro che non possono
condurre questo tipo di vita (esicasta), rimangano sottomessi e combattano come
atleti e come martiri"; ed altrove: "chiariamo che tutti gli altri devono essere
sottomessi, sotto il governo e la direzione di un unico pastore"
(Meyer, op. cit., 118, pp.15-17;
21-22).
In questo brano, Atanasio afferma che dopo molto tempo, con molta fatica ed una
lunga esperienza, ha imparato che la cosa migliore era che “tutti i fratelli
vivano insieme e che insieme guardino verso la stessa meta di salvezza; che essi
formino nel cenobio un'unica volontà, un unico desiderio, che tutta la
Fraternità sia un corpo unico armoniosamente composto da membri diversi”. È
difficile immaginare un riassunto migliore dell'insegnamento di Teodoro.
Tuttavia, la concezione dell'hypotagé,
(sottomissione), sembra essere stata in pratica meno rigorosa a Lavra che nel
monastero di Studios; si tratta meno delle diaconie
[55] nei testi di Lavra che nelle catechesi
studite; l’hypotagé
(sottomissione) si modera verso l’hypakoé
(obbedienza).
L'obbedienza aveva certamente il suo posto nel monachesimo studita
[56], ma la sottomissione era più totale, più
esigente; ogni monaco doveva mostrarsi servitore dei suoi fratelli, meno con i
sentimenti che con il suo lavoro e la sua dedizione in ogni momento. Inoltre, a
Lavra, è l'hypakoé che diventa il
criterio della vera hypotagé: "che i
fratelli dimostrino al loro superiore una vera, perfetta, sincera obbedienza,
perché la vera e irreprensibile sottomissione dei cenobiti nei confronti del
loro egumeno, consiste non solo nell'evitare ciò che il giudizio del superiore
vieta, ma anche nel non fare ciò che è lodevole, senza il suo permesso“
(Meyer, op. cit. p.115.).
Non è impossibile che ci sia una reminiscenza della regola benedettina
[57]. C'è in ogni caso una nuova sfumatura
che viene introdotta nella concezione della sottomissione cenobitica; essa
avvicina ancora di più la concezione monastica di Atanasio al monachesimo
occidentale incarnato nello spirito benedettino.
Questo è davvero ciò che è notevole nell'opera legislativa di Atanasio. In lui
si ri uniscono Teodoro Studita e Benedetto da Norcia, il Bizantino ed il Romano,
l'Oriente e l'Occidente. Se a Lavra l'accoglienza è fraterna anche per i monaci
d'Occidente, se vi troviamo più comprensione e possibilità di dialogo, questo è
indubbiamente dovuto all'intercessione del santo fondatore.
[1]
Esicasmo. Nel monachesimo cristiano orientale, il termine designa una
tradizione contemplativa che risale al IV secolo. I monaci esicasti (dal
greco, hesychìa, “quiete”), particolarmente quelli del monte Athos, si
dedicavano a un’incessante preghiera mentale per raggiungere l’unione
con Dio. Per concentrarsi e favorire l’estasi recitavano la preghiera di
Gesù, nota come “preghiera del cuore”, che consisteva generalmente nelle
parole: “Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore”
ripetuta incessantemente regolando il respiro conformemente alla
recitazione e contemplandosi l’ombelico (onfaloscopìa). (Fonte: "Microsoft
Encarta 2009")
[2]
Il termine deriva da askitìs,
“asceta”. Una skiti è costituita da un insieme di
kalyve (kalyva,
propriamente “capanna”, è la dimora di un singolo monaco o di una
piccola fraternità); ha un’amministrazione interna propria e tuttavia
dipende da un monastero sovrano. È governata dal
dikeos, eletto ogni anno
dall’assemblea degli anziani di tutte le kalyve, aiutato da quattro
consiglieri. Nei giorni festivi i monaci della skiti celebrano il culto
divino nel kyriakòn, la
chiesa centrale della skiti. (Fonte: "Monte
Athos", di Nikolaos Chatzinikolaou, Asterios Editore, Trieste, 2016)
[3]
Oltre ai vari stili spirituali della vita monastica, possono essere
menzionati tre tipi formali di organizzazione. Il primo è quello del
monachesimo cenobitico. In questo tipo tutti i membri della comunità
fanno tutte le cose in comune. La seconda forma è chiamata idiorritmica
(dal greco idios "proprio, particolare", rhythmos, "regola" o "ordine")
in cui i monaci o le monache pregano insieme liturgicamente, ma lavorano
e mangiano individualmente o in piccoli gruppi. In questo tipo di
monachesimo le persone possono persino salmodiare e fare gli uffici
separatamente, riunendosi solo per la liturgia eucaristica ed anche
allora, forse, solo in certe occasioni. Infine, vi è il tipo eremitico
del monachesimo in cui i singoli monaci o monache sono in realtà
eremiti, chiamati anche anacoreti o reclusi. Vivono in totale isolamento
individuale e non si uniscono mai alla preghiera liturgica della
comunità, eccetto di nuovo forse nelle occasioni più solenni. Nei casi
più rari può accadere persino che la Santa Eucaristia venga portata al
monaco o monaca che rimane perennemente sola. (Fonte: "The Orthodox
Faith" di Thomas Hopko - SVS Press 1981)
[4]
Il calogero è una figura religiosa caratteristica della chiesa ortodossa
di Grecia. Derivante dal greco
Καλόγερος
(Kalògheros),
che significa "buon vecchio", il termine indica dei monaci appartenenti
all'ordine basiliano, così detto perché basato sulla regola di san
Basilio Magno. Vivono per gran parte sul monte Athos e prestano servizio
presso le chiese d'oriente. Conducono una vita molto austera e ritirata,
basata sull'osservanza di quattro quaresime l'anno, molte penitenze e
lavoro nei campi, con un regime alimentare che esclude l'assunzione di
carne. (Foonte: “Wikipedia”)
[5]
Kellia, in greco.
Kellion – incontreremo ancora
questo termine – può indicare la cella (la stanza) del monaco o, come in
questo caso, l’abitazione monastica singola dipendente da uno dei venti
monasteri athoniti; vi può abitare un solo monaco o una piccola
fraternità dedita, di norma, a lavori di agricoltura; è un edificio
naturalmente più piccolo del monastero e della skiti, ma più grande
della kalyva; al Monte Athos ne esistono circa 140. (Fonte: "Monte
Athos", di Nikolaos Chatzinikolaou, Asterios Editore, Trieste, 2016)
[6]
Non conosco statistiche precise su questo argomento. I. Doens,
Monastères orthodoxes en Grèce, in "Irénikon", 34, 1961, p. 358,
pubblicò una tabella presa in prestito da N.G. Mylona-Kos,
”Αγιον”
Oρος
καί Σλαϋοι,,
Atene, 1960. Secondo questa tabella, c'erano nel 1959, 1641 monaci sulla
Santa Montagna, di cui 735 erano nei venti grandi monasteri. C'erano
quindi in questo periodo 906 monaci "exartimatikoi". Ma non tutti
conducevano una vita di tipo esicasta; dovremmo sottrarre da questa
cifra il numero di monaci che vivono nelle skiti, alcune delle quali
sono importanti quanto i monasteri. Non credo che i monaci che vivono
nelle kellia o negli eremi siano più di tre o quattrocento.
[7]
Ci sono sempre state correnti diverse e talvolta contraddittorie nel
monachesimo. È deplorevole che questo fatto fondamentale non venga
tenuto maggiormente in considerazione. Tuttavia, confrontandosi e stando
accanto, queste varie forme di spiritualità sono inevitabilmente portate
ad influenzarsi a vicenda. Anche nel monachesimo occidentale, sarebbe
facile identificare diverse tendenze spirituali che si compenetrano.
Tanto più nell'Athos, dove i monasteri e le kellia sono così vicine tra
loro e sono chiamate, per lo statuto stesso della Santa Montagna, ad
avere rapporti numerosi e continui.
[8]
Amand De Mendieta.
“Le Mont-Athos. La presqu'île des
caloyers”. Bruges: Desclée de Brouwer, 1955
[9]
I monaci del Monte Athos, definendo un limite al loro territorio, la
Grande Vigla, escludevano da Athos il monastero di Kolovos ed
eliminavano la possibile influenza di questo monastero e di una
spiritualità diversa da quella che intendevano praticare. Il loro
atteggiamento successivo verso sant'Atanasio è ispirato dalla stessa
preoccupazione.
[10]
I dettagli forniti dalla vita di sant’Eutimio il Giovane permettono di
vedere che il monastero "tôn
Pissadinôn" era sicuramente cenobitico. … Che abbia appartenuto o
meno alla confederazione studita, sembra certo che questo monastero
abbia subito l’influenza della riforma cenobitica di Teodoro Studita; in
effetti era situato nella valle del Kilissé Déré, come il monastero
studita dei Simboli. Si veda B. Menthon,
L’Olympe de Bithynie, Paris,
1935, pp. 163-164.
[11]
Ci sono due vite di sant'Atanasio l'Atonita: la
Vita A, a cura di I.
Pomjalovskij, Zitie prepodobnago
Athanasija Athonskago, San Pietroburgo, 1895, e la
Vita B, a cura di L. Petit,
Vie de saint Athanase l'Athonite,
in "Analecta Bollandiana",
25, 1906, pp. 12-87. È generalmente accettato che la
Vita B sia solo una nuova
redazione della Vita A.
Potrebbe essere che la Vita B
abbia, per alcuni punti, una fonte di documentazione migliore della
Vita A. Citerò qui solo la
Vita B, indicando pagina e
righe dell'edizione (che io ho riportato solo parzialmente. Ndt.).
[12]
Secondo la Vita B Atanasio mangia solo pane d’orzo ed una volta ogni due
giorni. Beve solo acqua, lotta contro il sonno e pratica altre pratiche
più abituali agli eremiti che ai cenobiti.
[13]
Alcuni di questi monasteri sono molto famosi: monasteri di Dalmata,
Dios, Bassos, Stoudios, Pégé ecc ... In genere si hanno pochissime
informazioni sulla vita religiosa di questi monasteri cenobitici nella
prima metà del X sec. Stando a quattro catechesi inedite di un igumeno
del monastero di Stoudios, che risalgono a questo periodo, la vita
cenobitica era in declino. Questo, credo, spiega in parte il nuovo
orientamento spirituale di Simeone lo Studita (o Eulabès) e del suo
discepolo Simeone il Nuovo Teologo (949-1022). Il declino di
un'istituzione monastica provoca molto spesso una riforma, ma è raro che
questa riforma sia un ritorno all'ideale originario di questa
istituzione. Generalmente si cerca di dare nuova vita all'istituzione,
introducendo principi di vita spirituale presi a prestito da una
corrente contemporanea che è in piena espansione. Così, nel XVI e XVII
secolo, sul Monate Athos le riforme dell'idiorritmia non portarono a un
ritorno al cenobitismo, ma alla creazione degli Skiti. Allo stesso modo
in Occidente, nel Medioevo, molti riformatori del cenobitismo non
cercarono di riscoprire il significato del cenobitismo ritornando allo
spirito della Regola, ma introdussero nel cenobitismo elementi di
spiritualità eremitica.
[14]
Riguardo ai monasteri dell'Olimpo si veda il sommario, ma nondimeno così
prezioso, lavoro di B. Menthon, l'Olympe de Bithynie, Paris, 1935. A
metà del X secolo, che cosa erano diventati i monasteri dell'Olimpo
fondati per la maggior parte nell'VIII e IX secolo? Abbiamo pochissime
informazioni su di essi. La maggior parte di essi certamente esisteva
ancora. È un dato di fatto che, salvo eventi straordinari, i monasteri
sopravvivono molto a lungo dopo un periodo più o meno lungo di
prosperità. Alcune importanti testimonianze ci forniscono la prova di
questa sopravvivenza del monachesimo dell'Olimpo nel suo insieme.
Costantino Porfirogenito visita il Monte Olimpo poco prima della sua
morte (959) ed il racconto di questa visita - che occupa un posto
importante nella cronaca dello storico Leone il Diacono (circa 950-992)
"Theophanus continuatus": PG 109, pp. 481-484 - mostra l'alta stima che
c'era a Costantinopoli per questo centro monastico. Nel 970 un asceta
dell'Olimpo, Basilio lo Scamandrino, fu nominato patriarca (PG 117, pp.
804-808 e 889-892). Intorno al 990, un igumeno dell'Olimpo porta una
lettera del patriarca Nichola II Crisoberge al principe Simeone di
Bulgaria (PG 111, 80 C).
[15]
Abido (o Abydos, secondo
l'originale greco-latino in uso presso altre lingue) è un'antica città
della Misia, in Asia Minore, situata a Nara Burnu sul miglior approdo
presente sul lato asiatico dell'Ellesponto, lo stretto dei Dardanelli,
(in Turchia). Di fronte, sul lato europeo, dall'altra parte dello
stretto, si trova Sesto, nel Chersoneso Tracico. Queste due città
segnano gli estremi del passaggio più breve tra le due sponde dei
Dardanelli, che in questo punto si restringono a poco più di un
miglio.(Fonte "Wikipedia")
[16]
Vita B, 18, 13. Il biografo non specifica le ragioni di questa
predilezione del giovane Avraamios per l'Athos, ma è chiaro che solo il
gusto ed il desiderio di una vita eremitica, o quasi eremitica,
potrebbero avergli fatto desiderare di andare a vivere all'Athos, poiché
a quel tempo non esisteva alcun monastero cenobitico sulla Santa
Montagna.
[17]
Michele Maleinos (Costantinopoli, 894 – 961) è stato un monaco cristiano
bizantino. Zio dell'imperatore bizantino Niceforo II. Alla nascita ebbe
il nome di Manuele Maleinos (Μανουήλ Μαλείνος) rampollo di una delle più
potenti e influenti famiglie della Cappadocia. Crebbe alla corte di
Leone VI il Saggio, alla morte del monarca, giovane diciottenne,
abbandonò il mondo per ritirarsi in solitudine in Bitinia. Qui fondò,
sul monte Kyminas, una lavra (monastero). Presso questo monastero mosse
i suoi primi passi il fondatore della Repubblica del Monte Athos
Atanasio l'Atonita. (Fonte "Wikipedia")
[18]
C. Korolevskji, Athos, in
“Dictionnaire d’Histoire et de Géographie écclésiastiques”, t. V, col.
74: “Il sistema studita era già adottato da san Michele Maleinos per il
monastero del Monte-Kyminas, e sant’Atanasio non fece fatica a farlo
trionfare sul monte Athos”.
[19]
L. Petit, Vie de saint Michel Maléinos, in “Revue de l’Orient chrétien”,
7, 1902, pp.545.546, e 566.
[20]
Esso è chiamato μοναστήριον (monasterion)
(558,5 e 554,30) e non χοινόβιον (koinobion).
Senza dubbio al suo interno si vive una certa vita comune: uffici
liturgici e pasti, ma l’austerità del vestiario e del sonno e la
possibilità di passare rapidamente alla vita eremitica indicano che si
tratta di una laura.
[21]
Nell’VIII e IX secolo, i monasteri dell’Olimpo sembrano non aver
conosciuto l’autentica vita cenobitica prima della riforma studita. Il
ritorno ad un cenobitismo integrale appare nei monasteri dell’Olimpo che
dipendono dal monastero di Stoudios e nei monasteri della confederazione
di cui san Pietro d’Atroa è il fondatore.
[22]
Sembra che a partire da questo periodo Michele ne scende al monastero
neanche alla domenica, come aveva l’abitudine di fare.
[23]
làura (o lavra) [che
in epoca antica significa « cammino, strada » e poi « quartiere »]. —
Organizzazione monastica bizantina. Distinta dall’eremo (dove il monaco
vive solo) e dal cenobio (ove il monaco vive in comunità, in celle
separate ma cinte da un muro), la 1aura indicava un gruppo più o meno
grande di celle monastiche (per lo più formate di piccole capanne o di
grotte scavate nel terreno arido e roccioso), ognuna separata dalle
altre, ma con una chiesa in comune e con un sacerdote che amministrava i
sacramenti e, spesso, ma non sempre, guidava i monaci nella vita
spirituale (anacoreti perciò nel senso stretto della parola). Prime
laure pare siano state quelle di Faran, nel deserto di Giuda, in
Palestina, e di Gerico sorte entrambe per iniziativa di s. Caritone
(323-330); ben presto altre ne sorsero con un massimo di fioritura nel
sec. 5°, specialmente
per merito di s. Eutimio il Grande e del suo discepolo s. Saba. Numerose
laure scavate nella roccia, e frequentate sino al 13° sec, ed oltre, si
trovano in Puglia e in Basilicata, interessanti, oltretutto, per gli
affreschi che ricoprono celle e oratori. Altre laure scavate nella
roccia, di grande interesse per l’architettura e per la pittura, sono in
Cappadocia. Singolare la situazione del monastero delle Meteore in
Grecia. Distrutte in Palestina dai Persiani e poi dagli Arabi nel sec.
7°, le laure nelle altre regioni, anche per conseguenza di abusi sorti
per la scarsa disciplina dei monaci, si trasformarono in veri e propri
cenobi, e la parola 1aura divenne sinonimo di monastero, restringendosi
anzi, più tardi, ad indicare solo quei monasteri celebri per numero e
santità di monaci. In questo senso famose sono la laura di s. Saba a
Gerusalemme, del monte Sinai e la Grande Laura del monte Àthos, ancora
oggi esistenti. (Fonte: “ora-et-labora.net”)
[24]
Vita B, 23, pp.7-14; questa precisa descrizione della vita atonita
all’arrivo di Atanasio ci permette di meglio misurare la sua evoluzione
spirituale e di comprendere l’ostilità che essa suscita.
[25]
Vita B, 28, p. 18; il luogo, si dice, dove ora si innalza il
kellion di Aghia Triada
(monastero della Santa Trinità nei pressi della città di Kalambaka che
si trova in Grecia nella periferia della Tessaglia. Ndt.), sulla strada
del (monastero) Roussikon.
[26]
Questo bisogno di scusare il lavoro di Atanasio è significativo della
spirituaità atonita primitiva: il lavoro manuale, soprettutto quello di
Atanasio, che era calligrafo, era considerato come incompatibile con la
contemplazione; è senza dubbio la ragione per la quale il biografo
precisa che, malgrado il suo lavoro, Atanasio “conversava senza sosta
con Dio”.
[27]
Melana non si trova dove attualmente è collocata la Lavra, ma ad una
quindicina di minuti più in là, sopra il mare.
[28]
Nel suo Typicon, Atanasio
prevede il caqso in cui gli esicasti vegono tetati dall’accidia, “poiché
ciò succede agli esicasti”.
[29]
Niceforo II Foca, imperatore d'Oriente. - Apparteneva alla nobile
famiglia cappadoce dei Foca che era fra le più illustri e potenti
dell'aristocrazia bizantina e che aveva dato all'impero generali di
grande valore. Seguendo la tradizione della famiglia, entrò giovanissimo
nell'esercito (era nato intorno al 912) elevandosi rapidamente ai più
alti gradi. Nel 960 fu posto a capo di una spedizione contro gli Arabi
di Creta, dove riportò una strepitosa vittoria espugnando Chandax
(Candia) e conquistando l'isola (961) ….. Con la partecipazione di sua
moglie fu ordita una congiura militare contro di lui. Della congiura
Niceforo ebbe avviso da delatori anonimi, ma non riuscì a scoprir nulla
di concreto e nella notte fra il 10 e l'11 dicembre 969 egli fu dai
cospiratori, a capo dei quali era Giovanni Zimisce, penetrati col favore
di Teofano nel suo appartamento del Bucoleon, barbaramente assassinato.
(Fonte "Enciclopedia Treccani")
[30]
Epistasìa: (ἡ
ἱερὰ
ἐπιστασία)
Organismo costituito da quattro membri, detti epistati, eletti dai
rappresentanti dei venti monasteri della confederazione del monte Athos.
Detiene il potere esecutivo e giudiziario nel territorio della Sacra
Montagna. È presieduta da uno degli epistati, eletto per cinque anni,
detto protos. (Fonte: "Piccolo
glossario dei termini liturgici ed ecclesiastici bizantini", di
Giovanni Fabriani, Roma 2020, www.liturgiabizantina.it)
[31]
« Eutimio di Tessalonico visse tre anni in un eremo dell'Athos, poi
circa nell'862 divenne capo di una laura. L'esistenza di simili laure è
attestato a Karyès, Zygou et à Xéropotamou » (E. Amand de Mendieta,
Le Mont-Athos, 12).
[32]
Michele Maléinos è morto il 12 luglio 961 (L. Petit, Vie de San Michele
Maléinos, in "Revue de l'Orient
Chrétien", 1902, p. 59 1), ed è nel settembre dello stesso anno che
Metodio, igumeno della laura di Maléinos, va in missione nell'Athos.
[33]
Questo kathisma porta attualmente il nome di kathisma del Prodromo e si
trova a cinque minuti di distanza da Lavra sopra il monastero.
[34]
Vita B, 35, p. 7; la
disposizione delle celle rettangolari intorno alla chiesa sembra essere
stata una consuetudine nei
coenobia. Se ne trovano molti esempi nei monasteri palestinesi, a
partire dal VII secolo. ; si veda V. Corbo,
L'ambiente materiale della vita
dei monachi di Palestina nel periodo bizantino, in “Il monachesimo
Orientale”, Roma, 1958, specialmente, pp. 246-257. Riguardo alla Lavra,
si noterà che il biografo non si accontenta di dire che le celle sono
disposte in un rettangolo, ma anche che si toccano (35, 8), ciò che
mostra perfettamente l'orientamento cenobitico della costruzione.
[35]
Il monastero della Lavra è il solo monastero atonita che non sia andato
a fuoco e che, quindi, non sia stato ricostruito. Alexandros Lavriotis,
op. cit., 130, et A. Deroko, Deux
genres d'architectures dans un monastère, dans «Revue des Études
byzantines» (Mélanges Raymond Janin), XIX, 1961, p. 385.
[36]
V.
Corbo,
op. cit.,
238, scrive: « sarà quindi sufficiente dare uno sguardo alle rovine dei
cenobi per capire anche come fosse costruito il nucleo centrale delle
laure, che in fondo non era che un piccolo cenobio in miniatura».
[37]
È praticamente impossibile conoscere attualmente la pianta delle laure o
degli altri monasteri dell'Olimpo. Nessuno dei monasteri, il cui sito è
stato identificato da P. Menthon, offre resti sufficienti per consentire
l'identificazione della sua pianta. Solo scavi metodici permetterebbero
senza dubbio di conoscere la disposizione di questi monasteri. Così per
il monastero di Pélécète: "basta raschiare il terreno ricoperto da un
sottile prato, per incontrare blocchi di muratura bizantina" (B.
Menthon, L'Olympe de Bithynie, Parigi, 1935, p. 38). Le dimensioni del
nucleo centrale di alcune laure palestinesi si trovano nell'articolo
citato da V. Corbo; la più grande, la laura degli Elioti, 50 metri per
50; la più piccola 15 su 15. Il monastero della Lavra ha proporzioni
altrimenti imponenti.
[38]
La permanenza nella laura, prima di partire verso la solitudine, non è
mai molto lunga. Abbiamo visto prima che è stata di tre anni per Michele
Maleinos e di quattro anni per Atanasio.
[39]
Mi sembra che ciò che caratterizza l'autentico cenobitismo, così come lo
troviamo in testimoni così diversi come i santi Pacomio, Basilio,
Benedetto e Teodoro Studite, sia la volontà di condurre soprattutto una
vita conforme allo spirito del Vangelo ed al perfezionamento di quello
spirito. Da qui l'importanza della carità pratica, concreta e di una
ricerca meno definita della pura contemplazione. Mentre gli antichi
sembrano aver chiaramente distinto l'ideale cenobitico dall'ideale
eremitico, tutto orientato alla contemplazione, ci si può chiedere fino
a che punto gli scrittori moderni che la pensano diversamente non si
lasciano trasportare da un patrimonio di spiritualità medievale,
fortemente marcato da autori come lo Pseudo-Dionigi l'Areopagita e
Gregorio Magno. Il dibattito è attuale ed è con cautela che tutti gli
elementi devono essere considerati.
[40]
Sembrerebbe chiaro che, scegliendo Eutimio, l'egumeno del monastero di
Studios, per arbitrare il conflitto tra i solitari di Athos e S.
Atanasio, Giovanni Zimisce volesse attirarsi le grazie del fondatore di
Lavra e farsi perdonare l'omicidio di Niceforo Foca. Aveva quindi capito
molto bene il significato cenobitico dell'opera di Atanasio e che questa
poteva essere approvata solo da un cenobita.
[41]
L’influenza della dottrina monastica de S. Teodoro Studita, e plus in
particolare dell’ipotiposi studita, si manifesta non solo a Bisanzio e
nell’Olimpo (Ph.
Meyer,
Die Haupturkunden für die Geschichte der Athosklôster,
pp. 15-20), ma anche nell’Italia meridionale : su questo tema si veda T.
Minisci,
Riflessi studitani nel monachesimo italo-greco,
nell’opera già citata « Il monachesimo orientale », pp. 215-233, e nei
paesi slavi : « L’influence studite rentre dans la plus authentique
tradition du monachisme russe. Fin dal X secolo, san Teodosio di
Pečerska, (o Teodosio di Kiev - Vasilev, 1029 circa – 3 maggio 1074)
fece tradurre il regolamento studita,
l’oustav
stouditskij,
per la laura delle Grotte di Kiev. La maggior parte dei monasteri russi
hanno seguito l’esempio della laura delle Grotte e, pur non dicendosi
studite, si sono conformate all’osservanza dello Studion» : L.
Gillet,
in « Revue liturgique et monastique», pp. 204-205 ; si veda anche M. J.
Rouet de
Journel,
Monachisme et monastères russes,
Paris, 1952, p. 33.
[42]
Sembra che l'ingresso alla Santa Montagna fosse proibito alle donne
molto prima che Atanasio arrivasse ad Athos. Le rivendicazioni dei
monaci atoniti contro le ingerenze di Giovanni Kolovos, la loro lotta
contro le innovazioni di Atanasio che accusano di aver introdotto il
mondo sulla montagna, dimostrano il loro desiderio di farne una terra
protetta dalle tentazioni del mondo. Infatti, mentre troviamo vicino
all'Olimpo monasteri di donne accanto a monasteri di uomini (ad esempio
a Mantinéon, e nella confederazione di S. Pietro d'Atroa), non
conosciamo l'esistenza di nessun monastero femminile in Athos, né la
presenza di una sola asceta. D'altra parte, è del tutto possibile che il
divieto di animali femmine sia stato importato da Atanasio che lo prese
in prestito da Teodoro Studite. Questo divieto non ha nulla a che fare
con la moralità sessuale, come pensiamo troppo spesso e come sembra
suggerire lo stesso Testamento di Teodoro (PG 99, 1280 A 4). Va sempre
di pari passo, nei testi teodoriani più antichi, con il divieto di avere
dei servitori. Pare che il riformatore studita volesse in questo modo
impedire ai suoi monasteri di vivere con il reddito di greggi allevati
da dei salariati, costringendo così i suoi monaci a lavorare manualmente
per vivere e provvedere ai bisogni dei poveri.
[43]
Michele Maléinos prende il piccolo abito nel 912 ed il grande abito
quattro anni dopo (L. Petit, op. cit., 553, 29 e 557, 7-8); Atanasio,
che aveva ricevuto il piccolo abito sul monte Kymina (Vita B, § 9),
ricevette il grande abito dalle mani dell'eremita Elia, dopo la
costruzione della chiesa di Lavra (Vita B, § 25).
[44]
Forse è semplicemente perché Atanasio aveva cambiato i giorni della
catechesi; è certo, in ogni caso, che egli faceva delle catechesi alla
sua comunità: Vita B, 55, 17
e Meyer, op. cit., 127, 10; i novizi erano ammessi in comunità al
momento della catechesi: Meyer, op. cit., 136, 4, ed il giorno della sua
morte Atanasio radunò i suoi monaci e "fece loro la catechesi del beato
Teodoro Studita" a cui aggiunse alcune riflessioni personali:
Vita B, 76, pp. 11-12.
[45]
Questi lemmi non dividono il testo in capitoli; essi sottolineano solo
alcuni paragrafi considerati senza dubbio come i più importanti;
avrebbero potuto scomparire senza difficoltà.
[46]
Per lo studita, il lavoro è la forma concreta che assume la
"sottomissione": J. Leroy, La
Réforme Studite, op. cit., pagg. 195-197, e in
Théologie de la vie monastique,
Parigi, 1961, pp. 434-435.
[47]
Meyer, op. cit., 138, p. 32 e ss. L'orario di lavoro è più o meno lo
stesso di quello dei lavoratori secolari; in Quaresima è ancora più
lungo: da Prima fino all'Ufficio della sera.
[48]
Nel monastero di Stoudios, che si trovava in città, il lavoro era
prevalentemente artigianale; a Lavra sembra essere stato prevalentemente
agricolo, come nei monasteri dell'Olimpo. In
Vita B si parla di
giardinaggio, di vigneti, di alberi da frutto, di cura dei muli, ma
anche di forgiatura, di calligrafia, per non parlare della cucina, della
panificazione ecc ...
[49]
Uno dei compiti più duri della vita monastica era lo
zymé; I fratelli lavoravano a
turno per impastare il pane. Sia nel monastero di Studios che a Lavra
c'era poca voglia di fare questo duro lavoro; Atanasio, riprendendo
un'idea di Teodoro Studita, fece costruire un'impastatrice meccanica
mossa da buoi: Vita B, pp.
62-63.
[50]
Sebbene l'ipotiposi studita non provenga da Teodoro, è certo che
l'egumeno del monastero di Studios aveva composto dei regolamenti; è
spesso menzionato nelle catechesi. Su questo punto si veda
La Reform Studite, op. cit.,
pagg. 208-210.
[51]
Questo punto della dottrina studita è fondamentale e meriterebbe uno
studio. Se ne trova un abbozzo in
La réforme studite, pp.199-200.
[52]
Lo stesso fenomeno si riscontra in Occidente; la Regola di San Benedetto
è chiarita ed integrata dalle "Declarationes
in Regulam" che passano, amplificandosi, da una Congregazione
all'altra. Queste stesse dichiarazioni sono ulteriormente chiarite,
all'interno di un monastero, da consuetudini locali o da usanze non
scritte che tuttavia hanno forza di legge; nessun dettaglio della vita
quotidiana viene trascurato. Si leggano, ad esempio, le Usanze di Cluny,
di Cîteaux o degli altri monasteri medievali!
[53]
È curioso notare che è, in definitiva, dal monastero di Studios che, con
Simeone Studita, è emerso il rinnovamento della tendenza esicasta, alla
fine del X secolo, come oggi è dal monastero cenobitico di Dionysiou,
che P. Théoklitos si è fatto il più caloroso apologeta della
spiritualità esicasta.
[54]
Stabilendo il principio che la vita cenobitica è superiore a tutte le
altre forme di vita monastica, perché è quella che ha condotto il
Signore, gli sembra inconcepibile che si possa passare dal cenobio
all'esichia: "si è innamorati dell'esichia, si desidera ardentemente e
si cerca una vita diversa da quella che il Signore ha dato; voi che
agite così, riflettete e vedrete che io non mento, perché parlo di cose
dalle quali io stesso sono stato tentato ”(Grandes
Catéchèses, libro III, cat. 31, inedito).
[55]
Le diaconie sembrano aver ricoperto un posto importante nella vita dei
monaci di Lavra, ma si deve riconoscere che la parola è relativamente
poco usata nei testi di Atanasio: Meyer,
op. cit., pagg. 126, 5; 127, 25 e 34; 129, 33.
[56]
Nel monachesimo studita, l'obbedienza al superiore, che manifesta la
volontà di Dio, si esprime concretamente con la sottomissione, la
remissività verso tutti i fratelli: "chi vuole veramente essere salvato,
cerca solo una cosa: la volontà di Dio, quella del suo superiore, e di
tutta la Fraternità ”(cat. 26 del libro I delle Grandi Catechesi). È la
dedizione ai fratelli nel lavoro che è il segno della genuina obbedienza
al superiore.
[57]
Regola di san Benedetto, cap XLIX, 8-9: “Ma anche ciò che ciascuno vuole
offrire personalmente a Dio dev'essere prima sottoposto umilmente
all'abate e poi compiuto con la sua benedizione e approvazione, perché
tutto quello che si fa senza il permesso dell'abate sarà considerato
come presunzione e vanità, anziché come merito. Perciò si deve far tutto
con l'autorizzazione dell'abate”. È vero che nella Regola l’obbedienza
non è limitata all’abate (Cap. LXXI,
ut oboedientes sibi sint invicem
– che tutti si obbediscano a vicenda), ma la dottrina dell’hypotagé
(sottomissione) cenobitica è lungi
dall’avere il vigore della concezione studita. Nella Regola predomina
l’hypakoé
(obbedienza).
Ritorno alla pagina su "Sant'Atanasio l'Atonita"
Ritorno alla pagina iniziale "Regole monastiche e conventuali"
| Ora, lege et labora | San Benedetto | Santa Regola | Attualità di San Benedetto |
| Storia del Monachesimo | A Diogneto | Imitazione di Cristo | Sacra Bibbia |
6 febbraio
2021 a cura
di Alberto "da Cormano"
![]() alberto@ora-et-labora.net
alberto@ora-et-labora.net